
Giochi e giocattoli dei bambini presso gli antichi Romani
di Grazia Merelli
Come già i Greci, anche gli antichi Romani davano molta importanza al gioco dei bambini. infatti il gioco era non solo un passatempo ma anche un’attività educativa, che aveva la funzione di preparare i giovani al mondo degli adulti.
Molti giochi e giocattoli del nostro tempo esistevano già in epoca romana: anche allora ci si divertiva con bambole, palle e trottole. Questi giochi erano diffusi presso un po’ tutte le civiltà antiche, le quali entravano in contatto fra di loro attraverso gli scambi del Mar Mediterraneo.

Al tempo dei Romani i bambini erano soliti giocare soprattutto dopo la scuola, nel pomeriggio, e durante alcune festività come i Saturnalia. Questa ricorrenza, nella quale si svolgevano banchetti e processioni, durava dal 17 al 23 dicembre ed in tale occasione i bambini ricevevano in dono dei giocattoli. Un’altra circostanza in cui i giovani romani ottenevano regali era per il loro compleanno.
Diversi poeti romani hanno parlato dei giochi e giocattoli del loro tempo, dandone talvolta un’accurata descrizione. Alcuni giocattoli sono giunti fino a noi; di altri c’è invece la testimonianza visiva delle opere d’arte che raffigurano scene di gioco.
Ai più piccoli erano destinati i sonagli e le trottole. I sonagli (crepundia), esattamente come oggi, servivano a distrarre i neonati facendo rumore. Avevano tante forme diverse per attrarre l’attenzione degli più piccoli. Alcuni campanellini venivano anche portati a tracolla dal bambino, tramite una catenina, ed erano dei portafortuna.Generalmente i sonagli erano in legno e bronzo, ma soprattutto in terracotta, che era molto economica sebbene più fragile. I sonagli in terracotta si rompevano facilmente e pertanto bisognava sostituirli frequentemente. Quelli arrivati fino a noi sono stati trovati nelle tombe come parte del corredo funebre dei più piccoli.
La trottola è un giocattolo antichissimo, molto amato anche dai Romani. Anche le trottole potevano essere di vari materiali, come legno, coccio e metallo. Per farle girare più velocemente, i giovani giocatori si aiutavano con una frusta.

Molto diffusi erano gli animali della fattoria e i cavallini trainabili. Nel Museo della Civiltà romana è conservato un cavaliere a cavallo in gesso, il cui originale in terracotta si trova a Colonia. Il cavallo è dotato di ruote così da poter essere trainato.

Tra i giochi più amati dai Romani vi era la palla (pila), un passatempo per tutte le età. Ce n’erano diverse tipologie, suddivise in base al gioco da fare e all’età dei giocatori. Un tipo di palla adatto ai bambini era il follis: si trattava di una palla leggera gonfiata ad aria. Probabilmente rimbalzava ed i bambini la tiravano fra loro.
Il follis era la palla adatta a chi aveva minore forza fisica, come riporta il poeta Marziale (Epigrammi, Liber XIV, carmen 47):
«Ite procul, iuvenes: mitis mihi convenit aetas:
Folle decet pueros ludere, folle senes»
«Giovani, allontanatevi: a me si addicono le età più quiete:
con il follis conviene che giochino i bambini, con il follis gli anziani”
Anche la paganica veniva usata dai bambini: si trattava di un pallone riempito di piume ed era molto usati dai fanciulli.

Rispetto alle altre civiltà antiche, i Romani dedicavano particolare cura alla fabbricazione delle bambole, dette a quel tempo pupae. Queste erano fatte di materiali come avorio, legno e terracotta. Le bambole avevano l’aspetto di adulte ed avevano la caratteristica di essere snodabili.
Le bambole erano considerate un giocattolo prettamente femminile; quando giungeva il momento di sposarsi le fanciulle dovevano lasciare le loro amiche d’infanzia al tempio della divinità.
Nel 1889, durante i lavori per la costruzione del Palazzo di Giustizia a Roma, è stata scoperta una tomba dove era custodita anche una bambola: si tratta della tomba di Crepereia Tryphaena. La ragazza, vissuta nella metà del II secolo d. C, era morta prima di convolare a nozze ed è per questo motivo probabilmente che la bambola è stata seppellita con lei.
L’affascinante reperto è molto ben conservato e si trova nella Centrale Montemartini. Si tratta di una bambola in avorio (divenuto scuro a causa dell’acqua), probabilmente colorata in origine. Come le altre bambole romane giunte fino a noi, ha l’aspetto di una donna e possiede gambe e braccia snodabili. I suoi capelli sono raccolti in un’elegante acconciatura, secondo la moda del tempo. La bambola aveva anche dei piccoli gioielli con sé, fatti di oro e pietre preziose. La bambola di Crepereia, insieme ad altri esemplari romani, mostra l’alto livello qualitativo cui era giunta la creazione delle bambole nell’antica Roma; infatti le pupae erano realizzate con cura, ricche di dettagli e dotate di movimento.

Adatti sia ai maschi che alle femmine erano invece le noci (nuces), con le quali si potevano fare tanti diversi giochi di abilità. In un poemetto attribuito a Ovidio e intitolato “Nuces”, vengono descritti vari giochi che si potevano fare con le noci. Fra essi vi era il Ludus Castellorum, nel quale bisognava lanciare una noce su un gruppo di tre, facendola restare in equilibrio. Invece nell’Orca si doveva tirare una noce all’interno di un’anfora. Le noci, così come le bambole, venivano considerate giochi – simbolo dell’infanzia, tanto che l’espressione “Lasciare le noci” indicava proprio la fine dell’età infantile.

A differenza delle noci, gli astragali o aliossi (tali) erano destinati sia agli adulti che ai bambini, i quali vi giocavano in un modo più semplice. Gli astragali sono degli ossicini di pecora o montone, che avevano quattro facce diverse (liscia, ruvida, concava e convessa). Come le noci, anche gli astragali andavano lanciati; però qui non si trattava di abilità ma di fortuna. Infatti il punteggio dipendeva da come cadevano, cioè dalla combinazione delle facce che venivano fuori.

Come i bambini di ogni tempo, anche quelli romani amavano rincorrersi e fare diversi giochi di movimento. Alcune pitture parietali documentano sia la mosca cieca che nascondino, detto all’epoca latibulo.
In un affresco proveniente da Ercolano, conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, tre amorini stanno giocando a nascondino. Quello a destra tiene gli occhi chiusi, facendo probabilmente la conta; l’amorino al centro sta correndo a trovare riparo mentre a sinistra, dietro la porta, si intravede l’ultimo dei tre personaggi che ha già trovato un buon nascondiglio. La scena risale al I secolo d. C. e mostra una grande freschezza narrativa. Nascondino è infatti un passatempo tanto semplice quanto longevo.
Nel complesso i bambini dell’antica Roma giocavano in modo simile a quelli del nostro tempo. Alcuni giocattoli odierni li troviamo già allora, come la bambola o la palla; altri invece, come gli astragali e le noci, sono andati via via scomparendo, lasciando il posto a nuovi passatempi altrettanto divertenti.
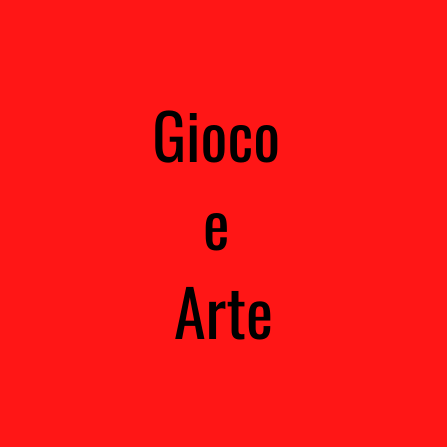
Lascia un commento